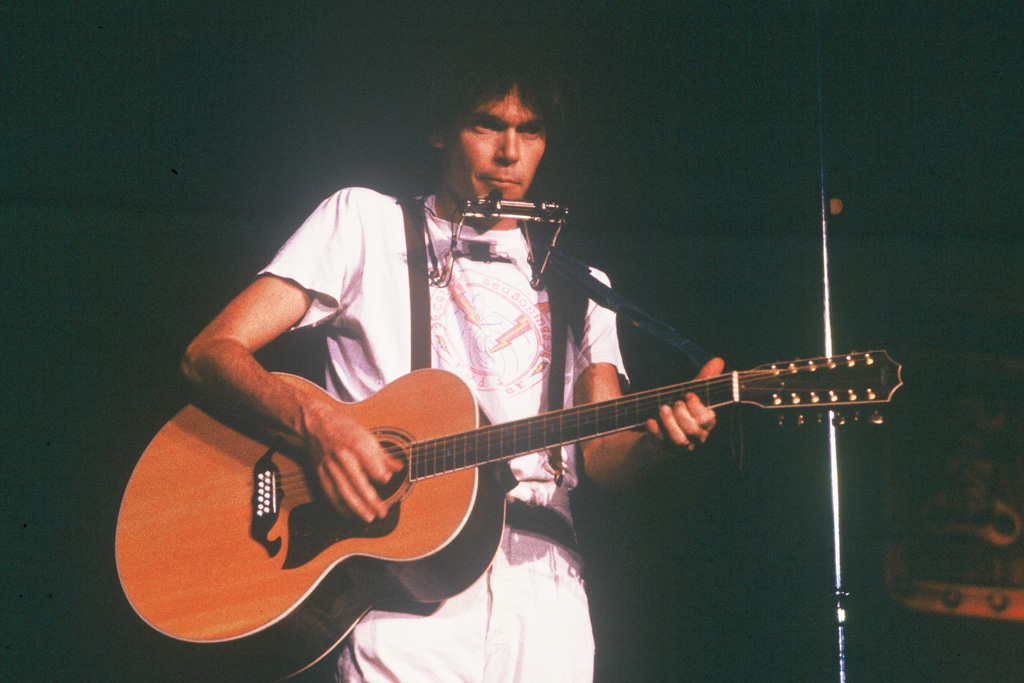Rust Never Sleeps / Live Rust - The Rolling Stone archives
RUST NEVER SLEEPS / LIVE RUST – 1979
Rolling Stone Music Awards 1979 – referendum dei lettori.
Artista dell'anno: 1° Neil Young
Album dell'anno: 1° Rust Never Sleeps
Miglior autore: 1° Neil Young
Miglior cantante uomo: 1° Neil Young
Per tutti coloro che sono ancora appassionatamente innamorati del rock ‘n’ roll, Neil Young ha fatto un disco che ne definisce il territorio o meglio che lo definisce, lo espande, lo esplode. Lo rade al suolo. Rust Never Sleeps mi dice più della mia vita, del mio paese, e del rock ‘n’ roll di ogni altra musica che io abbia mai sentito da anni a questa parte. Come un amico o un amante ritrovato che ti giura onestà ed è impaziente di condividere con te tutto ciò che può essere importante, questo album è allo stesso tempo un concentrato e una visione sinottica di… tutto: le rocce e gli alberi e le ombre tra le rocce e gli alberi. Allo stesso tempo i testi di Neil Young trasudano forza e speranza, mettono in guardia e portano cordoglio. Rust Never Sleeps è probabilmente l’epitaffio perfetto per la maggior parte di noi, ma può anche essere un richiamo all’azione. Su On The Beach del 1974 il cantante riassunse una canzone (“Ambulance blues”) e uno stato d’animo con una metafora fuori dai denti: “Credo che la chiamerò malattia avanzata”. Sullo stesso disco sentì lo stesso rinnovamento di energia che descrisse in “Motion pictures” con quello che può essere reputato uno dei versi più vanitosi ed egoistici del r ‘n’ r: “Sento che la montagna fa bene”, ma Rust Never Sleeps fa bene ad ogni precedente promessa di Young.
Come potete vedere, qui abbiamo a che fare con l’onniscenza, non con l’ironia. Troppo spesso l’ironia è l’ultima facile scappatoia per quelle teste di cazzo intelligenti che confondono un cuore con una trappola, che non riescono a trovare il centro delle cose perché il loro stare sul filo è fottutamente affascinante e che si ritengono troppo fighi per potergliene importare o per accettare commiserazione. Neil Young non ha di questi problemi perché attualmente sa chi è e contro cosa combatte, perché sembra essersi conquistato il suo punto di vista, perché la sua musica piena di brividi e di idiosincrasie è contraddistinta da una saggezza e da un’intelligenza straordinarie. Per tutti questi motivi Young se ne può uscire e dire qualunque cosa senza l’affanno, la retorica o la facile lezione morale di cui sembrano intrise le più recenti produzioni. Lui non ha bisogno di queste stronzate. Quest’uomo non riduce mai le sue canzoni al mero significato delle loro parole: ti dà la cosa intera, emozioni (e talvolta contraddizioni) controllate ma illimitate. Secondo me Neil Young surclassa chiunque nel rock ‘n’ roll di oggi sotto il profilo dello scrivere, del cantare, del suonare, del pensare, del sentire e del durare nel tempo. Di tutti i maggiori artisti rock che hanno iniziato negli anni Sessanta (Bob Dylan, Rolling Stones, Who, eccetera) è l’unico che è consistentemente meglio oggi di allora.
Artista dell'anno: 1° Neil Young
Album dell'anno: 1° Rust Never Sleeps
Miglior autore: 1° Neil Young
Miglior cantante uomo: 1° Neil Young
Per tutti coloro che sono ancora appassionatamente innamorati del rock ‘n’ roll, Neil Young ha fatto un disco che ne definisce il territorio o meglio che lo definisce, lo espande, lo esplode. Lo rade al suolo. Rust Never Sleeps mi dice più della mia vita, del mio paese, e del rock ‘n’ roll di ogni altra musica che io abbia mai sentito da anni a questa parte. Come un amico o un amante ritrovato che ti giura onestà ed è impaziente di condividere con te tutto ciò che può essere importante, questo album è allo stesso tempo un concentrato e una visione sinottica di… tutto: le rocce e gli alberi e le ombre tra le rocce e gli alberi. Allo stesso tempo i testi di Neil Young trasudano forza e speranza, mettono in guardia e portano cordoglio. Rust Never Sleeps è probabilmente l’epitaffio perfetto per la maggior parte di noi, ma può anche essere un richiamo all’azione. Su On The Beach del 1974 il cantante riassunse una canzone (“Ambulance blues”) e uno stato d’animo con una metafora fuori dai denti: “Credo che la chiamerò malattia avanzata”. Sullo stesso disco sentì lo stesso rinnovamento di energia che descrisse in “Motion pictures” con quello che può essere reputato uno dei versi più vanitosi ed egoistici del r ‘n’ r: “Sento che la montagna fa bene”, ma Rust Never Sleeps fa bene ad ogni precedente promessa di Young.
Come potete vedere, qui abbiamo a che fare con l’onniscenza, non con l’ironia. Troppo spesso l’ironia è l’ultima facile scappatoia per quelle teste di cazzo intelligenti che confondono un cuore con una trappola, che non riescono a trovare il centro delle cose perché il loro stare sul filo è fottutamente affascinante e che si ritengono troppo fighi per potergliene importare o per accettare commiserazione. Neil Young non ha di questi problemi perché attualmente sa chi è e contro cosa combatte, perché sembra essersi conquistato il suo punto di vista, perché la sua musica piena di brividi e di idiosincrasie è contraddistinta da una saggezza e da un’intelligenza straordinarie. Per tutti questi motivi Young se ne può uscire e dire qualunque cosa senza l’affanno, la retorica o la facile lezione morale di cui sembrano intrise le più recenti produzioni. Lui non ha bisogno di queste stronzate. Quest’uomo non riduce mai le sue canzoni al mero significato delle loro parole: ti dà la cosa intera, emozioni (e talvolta contraddizioni) controllate ma illimitate. Secondo me Neil Young surclassa chiunque nel rock ‘n’ roll di oggi sotto il profilo dello scrivere, del cantare, del suonare, del pensare, del sentire e del durare nel tempo. Di tutti i maggiori artisti rock che hanno iniziato negli anni Sessanta (Bob Dylan, Rolling Stones, Who, eccetera) è l’unico che è consistentemente meglio oggi di allora.
Anche se non è proprio un concept album Rust Never Sleeps è un disco sul rock ‘n’ roll, sul bruciarsi, sulle violenze contemporanee e storiche dell’America e sul desiderio o la necessità di fuggire qualche volta. È un’esortazione a tornare rivolta a coloro che ancora ne hanno la possibilità e un elegiaco tributo a chi non ce l’ha più. Tutto ciò è abbastanza chiaro. Ma, al contrario di molti dischi di Young, questo abbraccia volutamente una gran quantità di stili, dalla seriosità del sensibile cantautore di “Thrasher”, all’affascinante fantascienza di “Ride my Llama”, al country-rock di “Sail away” (un delizioso avanzo di Comes A Time cantato con Nicolette Larson) fino all’aperto abbraccio alla grezza potenza del punk dell’ilare e corrosivo commento sociale di “Welfare mothers”. Il primo lato è minacciosamente acustico: solo apparentemente una dimostrazione folkeggiante, in realtà si tratta di una virtuosa dimostrazione di come un rock ‘n’ roller possa staccare la spina e poi, attraverso la pura forza di volontà personale, decidere di incrementare di nuovo il voltaggio. Il lato b è travolgente rock ‘n’ roll dei Crazy Horse, anche se nel primo brano, “Powderfinger” è abbastanza stranamente la più pura narrazione folk dell’album. E per provare che è più di un semplice combattente Young butta fuori un brano come “My my, hey hey (out of the blue)” o “Hey hey, my my (into the black)” in versione acustica ed elettrica.
Rust Never Sleeps comincia con “My my, hey hey (out of the blue)” e in un istante si capisce (da quelle note ossessive e sinistre suonate dalle corde basse della chitarra, dal rispettoso e dimesso tono del cantato e dalla ripetizione delle parole) che questa canzone non è molto lontana dal nocciolo della questione. E qui il nocciolo della questione è morte e disperazione. E commercio. Mentre “out of the blue and into the black” (“fuori dal blu” – o “dalla tristezza” – e “dentro al nero” – o “nella disperazione”) è una frase piena di una mortale fatalità, “into the black” può anche significare soldi, successo e fama, cose che comportano tutte un alto prezzo: “My my, hey hey” canta Young, un verso fatalistico e derisorio allo stesso tempo, “il rock ‘n’ roll è qui per restare”. Vengono poi citati Elvis Presley e i Sex Pistols:
Il Re è andato ma non dimenticato/ Questa è la storia di Johnny Rotten/ È meglio bruciare che arrugginire/ Il Re è andato ma non dimenticato
Anche se Young crede che “il rock ‘n’ roll non può morire”, sa che molte persone in esso invece sì, muoiono. Velocemente. Da qui l’ammonimento finale: “C’è più dell’immagine che salta all’occhio”. Poi viene l’autobiografica “Thrasher” (in cui la trebbiatrice è la metafora della morte), ancora una canzone sulla distruttività del r ‘n’ r, inteso qui come stagnazione artistica che deriva dalla vita facile. Nel momento in cui il cantante racconta della caduta in basso di molti amici e colleghi,
Erano il miglior assortimento/ Furono avvelenati dalla protezione/ Non c’era nulla di cui avevano bisogno/ Non avevano più nulla da scoprire/ Si persero in formazioni rock/ O divennero panchine mutanti nel parco/ Sui marciapiedi e nelle stazioni/ Aspettavano, aspettavano,
decide che questo non succederà a lui:
Così mi stufai e li lasciai lì/ Erano solo pesi morti per me/ È meglio giù in strada senza quel fardello
Scritta in parte nel florido e fluente stile rock poetico di metà anni Sessanta e magnificamente suonata alla dodici corde e all’armonica, “Thrasher” è una composizione molto complessa che indugia profondamente su legami e limiti di realtà, ricordi infantili, paura, droga, industria musicale, prendendo duramente posizione sul proprio fare arte. Quando quest’ultima è minacciata, Young canta:
Allora ho capito che ne avevo abbastanza/ Feci fuori la carta di credito in cambio di carburante/ Mi diressi dove il selciato diventa sabbia/ Con un biglietto di sola andata per il paese della verità/ E la mia valigia in mano/ Ancora non capisco come ho perso i miei amici
Rust Never Sleeps comincia con “My my, hey hey (out of the blue)” e in un istante si capisce (da quelle note ossessive e sinistre suonate dalle corde basse della chitarra, dal rispettoso e dimesso tono del cantato e dalla ripetizione delle parole) che questa canzone non è molto lontana dal nocciolo della questione. E qui il nocciolo della questione è morte e disperazione. E commercio. Mentre “out of the blue and into the black” (“fuori dal blu” – o “dalla tristezza” – e “dentro al nero” – o “nella disperazione”) è una frase piena di una mortale fatalità, “into the black” può anche significare soldi, successo e fama, cose che comportano tutte un alto prezzo: “My my, hey hey” canta Young, un verso fatalistico e derisorio allo stesso tempo, “il rock ‘n’ roll è qui per restare”. Vengono poi citati Elvis Presley e i Sex Pistols:
Il Re è andato ma non dimenticato/ Questa è la storia di Johnny Rotten/ È meglio bruciare che arrugginire/ Il Re è andato ma non dimenticato
Anche se Young crede che “il rock ‘n’ roll non può morire”, sa che molte persone in esso invece sì, muoiono. Velocemente. Da qui l’ammonimento finale: “C’è più dell’immagine che salta all’occhio”. Poi viene l’autobiografica “Thrasher” (in cui la trebbiatrice è la metafora della morte), ancora una canzone sulla distruttività del r ‘n’ r, inteso qui come stagnazione artistica che deriva dalla vita facile. Nel momento in cui il cantante racconta della caduta in basso di molti amici e colleghi,
Erano il miglior assortimento/ Furono avvelenati dalla protezione/ Non c’era nulla di cui avevano bisogno/ Non avevano più nulla da scoprire/ Si persero in formazioni rock/ O divennero panchine mutanti nel parco/ Sui marciapiedi e nelle stazioni/ Aspettavano, aspettavano,
decide che questo non succederà a lui:
Così mi stufai e li lasciai lì/ Erano solo pesi morti per me/ È meglio giù in strada senza quel fardello
Scritta in parte nel florido e fluente stile rock poetico di metà anni Sessanta e magnificamente suonata alla dodici corde e all’armonica, “Thrasher” è una composizione molto complessa che indugia profondamente su legami e limiti di realtà, ricordi infantili, paura, droga, industria musicale, prendendo duramente posizione sul proprio fare arte. Quando quest’ultima è minacciata, Young canta:
Allora ho capito che ne avevo abbastanza/ Feci fuori la carta di credito in cambio di carburante/ Mi diressi dove il selciato diventa sabbia/ Con un biglietto di sola andata per il paese della verità/ E la mia valigia in mano/ Ancora non capisco come ho perso i miei amici
Se questi versi riportano alla mente il lato di On The Beach con la sequenza “On the beach”/ “Motion pictures”/ “Ambulance blues” è perché a quello si riferiscono. Anche quella sequenza di canzoni diceva di sopravvivere con dignità. Se prese come entità unica unità, “My my, hey hey” e “Thrasher” suggeriscono quasi una parafrasi del padre di frontiera che mette in guardia il figlio in “Powderfinger” sul secondo lato: il rock significa corri, figliolo, i numeri aggiunti non significano nulla. Ma Young non è così incline a fare prediche. Se è abbastanza forte per andarsene, lo è anche per rimanere a lavorare. È in grado di adattarsi (“Potrei vivere in un teepee/ Potrei morire in Penthouse trentacinque”). Lui seppellirà la sua morte e forse ci farà sopra anche un macabro scherzo: “Ricordi Forte Alamo quando stavano per arrivare i rinforzi/ È meglio qui e adesso, mi sento proprio così bene oggi”. Nonostante la professione possa essere pericolosa, è anche gloriosa e alla fine ne è orgoglioso (“Consegnare berline è un lavoro che so che mi terrò/ È stato difficile trovarlo”). Nel feroce finale di “Hey hey, my my (into the black)” coi Crazy Horse, Neil Young fa apparire il r ‘n’ r sia meravigliosamente assassino, sia terribilmente trionfante, con quella batteria che schiocca come una frusta, le chitarre che sfondano come cannoni e la voce che si eleva sopra quel baccano rosso sangue come una bandiera che continua a sventolare: “È questa la storia di Johnny Rotten?” si chiede. Si e no. Se non riusciamo a capirlo, possiamo star certi che ci proveremo fino alla morte, sembra voler dire. Sono forse l’ultima persona al mondo che può affermare che le due migliori canzoni dell’album sul r ‘n’ r, “My my, hey hey (out of the blue)”/ “Hey hey, my my (into the black)” e “Thrasher”, hanno qualche diretta connessione con “Pocahontas” e “Powderfinger” in comparazione all’America. Naturalmente sono anche l’ultima persona al mondo che può negarlo. “Pocahontas” è semplicemente incredibile e solo Neil Young avrebbe potuto scriverla. È una quieta saga sugli indiani d’America con questi amabili versi:
Aurora boreale/ Il cielo ghiacciato dalla notte/ Pagaie tagliano l’acqua/ In un folo lungo e concitato
Poi salta velocemente dalle visioni coloniali ai massacri della cavalleria, fino ai sobborghi urbani e alle assurdità tragicomiche dei nostri giorni:
E forse Marlon Brando/ Sarà là al fuoco/ Staremo a parlare di Hollywood/ E delle belle cose che ti affittano là/ E dell’Astrodome e del primo teepee/ Marlon Brando, Pocahontas e io
Con “Pocahontas” Young naviga nel tempo e nello spazio come se gli appartenessero. In un solo verso attraversa tutto un secolo: “Hanno massacrato i bisonti/ Messi in un angolino dalla banca”. Si lancia persino in un flashback (con un gioco di parole osceno) talmente pazzo e toccante che l'ascoltatore non sa se ridere o piangere:
Avrei voluto essere un cacciatore di pelli/ Ne avrei date un migliaio/ Per dormire con Pocahontas/ E scoprire come si è sentita/ Al mattino sui prati verdi/ Nella terra natìa che non abbiamo mai visto
Cercate di ridurre ciò ad un’unica emozione. Come l’attacco degli elicotteri nell’enormemente ambizioso Apocalipse Now di Francis Ford Coppola, la violenza di “Powderfinger” è allo stesso tempo spaventosa e seducente, sia per noi che per il suo narratore, per poi scoprire che è troppo tardi. In questo racconto del vecchio West, un giovane lasciato a guardia di un piccolo insediamento si ritrova assediato e non riesce a sopportare di rimanere lì a fissare i proiettili che gli sfrecciano accanto: “Avevo appena compiuto ventidue anni/ Mi stavo chiedendo cosa fare”. Tra una strofa e l’altra Neil Young dà una stretta di vite al suo giovane eroe con dei galvanizzanti assoli di chitarra, mentre i Crazy Horse liberano tutto ciò che hanno: la tensione è traumatizzante, la nostra empatia e fascinazione insopportabile, e Young non ci permette di distrarci: “Quando il primo sparo colpì la banchina li vidi arrivare”, dice il ragazzo, e anche noi siamo in ansia con lui. Nascosta sotto le parole c’è, come dice Greil Marcus, “quel filo di note ascendenti tagliate da un mortale accordo discendente, ovvero il fatalismo in un fraseggio”. L’eroe agisce: “Puntai il fucile e presi la mira/ Senza mai smettere di chiedermi il perché”. Young preme il grilletto. Il narratore dice: “Poi vidi nero e la mia faccia esplosa in cielo”. Ma non finisce qui, infatti il ragazzo morto aggiunge un’altra strofa:
Dammi riparo dalla polvere e dal dito/ Ricoprimi col pensiero che ha premuto il grilletto/ Solo pensami come non ti sei mai immaginato/ Svanito così giovane/ Con tante cose lasciate incompiute/ Ricordami al mio amore, so che le mancherò
Il re è andato ma non è stato dimenticato. Anche questa potrebbe essere la storia di un Johnny Rotten. “Ehi, ehi, my, my il rock ‘n’ non può morire”. Neil Young dovrebbe avere l’ultima parola sulla propria musica, sul proprio futuro e su Rust Never Sleeps. Questi versi di “Thrasher” sono una magnifica dichiarazione d’intenti:
Ma io non mi fermo là, ho ancora il mio filare da seminare/ Solo un’altra linea nel campo del tempo/ Verranno le trebbiatrici e sarò fisso nel sole come i dinosauri nei musei/ Allora saprò che è arrivato il momento di dare ciò che è mio.
Paul Nelson, Rolling Stone 1979
Aurora boreale/ Il cielo ghiacciato dalla notte/ Pagaie tagliano l’acqua/ In un folo lungo e concitato
Poi salta velocemente dalle visioni coloniali ai massacri della cavalleria, fino ai sobborghi urbani e alle assurdità tragicomiche dei nostri giorni:
E forse Marlon Brando/ Sarà là al fuoco/ Staremo a parlare di Hollywood/ E delle belle cose che ti affittano là/ E dell’Astrodome e del primo teepee/ Marlon Brando, Pocahontas e io
Con “Pocahontas” Young naviga nel tempo e nello spazio come se gli appartenessero. In un solo verso attraversa tutto un secolo: “Hanno massacrato i bisonti/ Messi in un angolino dalla banca”. Si lancia persino in un flashback (con un gioco di parole osceno) talmente pazzo e toccante che l'ascoltatore non sa se ridere o piangere:
Avrei voluto essere un cacciatore di pelli/ Ne avrei date un migliaio/ Per dormire con Pocahontas/ E scoprire come si è sentita/ Al mattino sui prati verdi/ Nella terra natìa che non abbiamo mai visto
Cercate di ridurre ciò ad un’unica emozione. Come l’attacco degli elicotteri nell’enormemente ambizioso Apocalipse Now di Francis Ford Coppola, la violenza di “Powderfinger” è allo stesso tempo spaventosa e seducente, sia per noi che per il suo narratore, per poi scoprire che è troppo tardi. In questo racconto del vecchio West, un giovane lasciato a guardia di un piccolo insediamento si ritrova assediato e non riesce a sopportare di rimanere lì a fissare i proiettili che gli sfrecciano accanto: “Avevo appena compiuto ventidue anni/ Mi stavo chiedendo cosa fare”. Tra una strofa e l’altra Neil Young dà una stretta di vite al suo giovane eroe con dei galvanizzanti assoli di chitarra, mentre i Crazy Horse liberano tutto ciò che hanno: la tensione è traumatizzante, la nostra empatia e fascinazione insopportabile, e Young non ci permette di distrarci: “Quando il primo sparo colpì la banchina li vidi arrivare”, dice il ragazzo, e anche noi siamo in ansia con lui. Nascosta sotto le parole c’è, come dice Greil Marcus, “quel filo di note ascendenti tagliate da un mortale accordo discendente, ovvero il fatalismo in un fraseggio”. L’eroe agisce: “Puntai il fucile e presi la mira/ Senza mai smettere di chiedermi il perché”. Young preme il grilletto. Il narratore dice: “Poi vidi nero e la mia faccia esplosa in cielo”. Ma non finisce qui, infatti il ragazzo morto aggiunge un’altra strofa:
Dammi riparo dalla polvere e dal dito/ Ricoprimi col pensiero che ha premuto il grilletto/ Solo pensami come non ti sei mai immaginato/ Svanito così giovane/ Con tante cose lasciate incompiute/ Ricordami al mio amore, so che le mancherò
Il re è andato ma non è stato dimenticato. Anche questa potrebbe essere la storia di un Johnny Rotten. “Ehi, ehi, my, my il rock ‘n’ non può morire”. Neil Young dovrebbe avere l’ultima parola sulla propria musica, sul proprio futuro e su Rust Never Sleeps. Questi versi di “Thrasher” sono una magnifica dichiarazione d’intenti:
Ma io non mi fermo là, ho ancora il mio filare da seminare/ Solo un’altra linea nel campo del tempo/ Verranno le trebbiatrici e sarò fisso nel sole come i dinosauri nei musei/ Allora saprò che è arrivato il momento di dare ciò che è mio.
Paul Nelson, Rolling Stone 1979
Accoppiando “Cortez the killer” di Zuma alla “Powderfinger” di Rust Never Sleeps Young delina il suo particolare sentimento romantico per la frontiera americana con un’acerba consapevolezza di come questa frontiera era agli inizi. All’interno di “Cortez the killer” Young opta per un’audace trasformazione cantando il verso “Venne danzando sull’acqua” in uno stile reggae tale da non solo mettere in connessione la storia di un colonizzatore sfruttatore con le odierne politiche nei confronti del Terzo Mondo, ma anche allineandosi con la musica politicamente più radicale dei nostri giorni. In un altro caso il senso che aveva la canzone viene cambiato dalla nuova enfasi data alla performance, facendo diventare la frase “È difficile trovare un lavoro” il punto focale di “Sedan delivery”, ripetendola continuamente sopra un galvanizzante riff chitarristico, il cantante trasforma il brano da piccola fantasia a inno sulla recessione. Young ha fatto il suo ingresso nel r ‘n’ r come suono puro nel 1975 con Zuma, dopo aver imparato ad usare il rumore grezzo con Tonight's The Night, ma non si è preparati alla portata e alla profondità dell’esecuzione che si ascolta su questo disco, così radicale e maestosa, piena di una forza lacerante. Invece di aumentare la velocità del ritmo nelle lunghe improvvisazioni, Young e i Crazy Horse lo rallentano a un’andatura quasi funerea, lasciando spazio tra le note corrosive disegnate dalla chitarra e una sorda e soffocata batteria. Poi fanno trasalire con un’improvvisa esplosione di sporco rumore. Le ultime due facciate di Live Rust si fondono in un enorme, oscuro canto funebre. Sono così massicce e maestose che danno l’impressione di una gigantesca montagna in movimento. Ancora: in “Cortez the killer” e nella scintillante “Like a hurricane” le chitarre sembrano fluttuare e scorrere come un fiume di lava che sfocia in “Hey hey, my my (into the black)” che Rust Never Sleeps era come un’eruzione dal nulla, forte e diretta come un telegramma. Qui è il culmine logico di tutto ciò a cui Live Rust tende, rock ‘n’ roll trattato allo stesso modo in cui un sudista può vedere la Guerra di Secessione (infatti nello spirito assomiglia più a “The night they drove old Dixie down” della Band che non a “Rock ‘n’ roll is here to stay” di Danny & the Juniors). “Hey hey, my my (into the black)” è sia una poesia da brivido sulla morte (con la voce di Young che si sforza valorosamente di portarti verso lunghe estensioni di spazi vuoti), sia una cupa e provocante ode alla sopravvivenza. Quando Neil Young canta “Il Re è andato, ma non dimenticato/ È questa la storia di Jonnhy Rotten?” è chiaramente Rotten che si piange, non Elvis Presley: Rotten ha incarnato l’estremo che Elvis ha rinnegato da tempo, l’estremo che lo stesso Young sta ora cercando di sostenere.
Segue “Tonight’s the night”. Sembra la naturale conclusione e acquista ancora più risonanza. Invece di essere solo su Bruce Berry e Danny Whitten, suona e appare come un elegia dedicata ai morti che si sono incontrati dall’inizio dell’album e più in generale per tutti gli anni settanta. L’evocazione di quel viaggio è lo scopo finale, la frase ricorrente in questo periodo è che il recente decollo dell’industria discografica sia “un’anticipazione degli anni ottanta”. Potrebbe forse essere applicata anche a questo disco, ma il vero messaggio di Live Rust è che il rito del paesaggio degli ultimi dieci anni dura anche oggigiorno (e notte): questo è l’importante.
Tom Carson, Rolling Stone 1980
Segue “Tonight’s the night”. Sembra la naturale conclusione e acquista ancora più risonanza. Invece di essere solo su Bruce Berry e Danny Whitten, suona e appare come un elegia dedicata ai morti che si sono incontrati dall’inizio dell’album e più in generale per tutti gli anni settanta. L’evocazione di quel viaggio è lo scopo finale, la frase ricorrente in questo periodo è che il recente decollo dell’industria discografica sia “un’anticipazione degli anni ottanta”. Potrebbe forse essere applicata anche a questo disco, ma il vero messaggio di Live Rust è che il rito del paesaggio degli ultimi dieci anni dura anche oggigiorno (e notte): questo è l’importante.
Tom Carson, Rolling Stone 1980
I 100 migliori album degli ultimi 20 anni – 66° Rust Never Sleeps
Ehi ehi, my my, il rock 'n' roll non morirà mai, perlomeno finché rocker come Neil Young continueranno a fare dei ritorni come Rust Never Sleeps, il risultato di un tour in cui suonò per la prima volta questi brani e ne registrò le basi dal vivo. Il disco arrivò dopo che per anni Young aveva sfornato incisioni opache o indifferenti. Questo disco non arrivò come un vero e proprio shock (Neil Young è un tipo da cui non ci si può attendere che segua un sentiero risaputo e scontato, nemmeno nel caso del suo declino artistico), ma una sorpresa deliziosa; per metà acustico e per metà elettrico, quest'album mostrò Young al lavoro con la profondità di un veterano e il vigore di un ragazzaccio. Una raccolta di favole complesse nello spirito degli Indiani d'America a fronteggiare un futuro incerto e minaccioso, Rust Never Sleeps tocca la maggior parte dei temi visitati da Young fin dagli ultimi anni '60 rimettendoli in una forma sonora inaspettatamente succinta e convincente. Sia che si venga attirati dal senso casalingo e folkeggiante delle sue canzoni acustiche, che dal trash indisciplinato del suo lavoro elettrico, si trova sempre qualcosa che piace in Neil Young: le ballate senza accompagnamento del primo lato sono le più amabili del suo repertorio, i rock della seconda facciata le più ruvide.
Il lato acustico si apre con “My My, Hey Hey (Out Of The Blue)”, un brano dalla forma così disadorna da farlo sembrare un affettuoso, simpatico saluto ai Sex Pistols e allo spirito del rock. “Thrasher” è una vivida e ossessionante ballata su (scegliete voi) la tecnologia incontrollata o su CSN. Le tre canzoni seguenti (“Ride My Llama”, “Pocahontas” e “Sail Away”) esplorano il fascino che da lungo tempo esercitano su Young gli spazi aperti e la nobiltà dei selvaggi. Le immagini sono indelebili, ma rese cruciali dalla loro intelligente asciuttezza. Giri il disco e trovi Young alle prese con la rabbia viscerale di Johnny Rotten a suonare l'hard rock più distruttivo che abbia mai fatto. “Welfare Mothers” e “Sedan Delivery” sono abrasive e brucianti, mentre “Powderfinger” cattura il sentimento della sopraffazione, di chi è alla deriva e condannato puntando il dito sulla prepotenza del potere. Infine c'è “Hey Hey, My My (Into The Black)” nella quale riprende la canzone iniziale suonandola con una furia controllata a malapena. Le due versioni drammaticamente differenti di questa canzone sono unite dalla semplice fede di Young nel potere trasformista del r'n'r, potere che mai prima d'ora aveva utilizzato così pienamente.
Rolling Stone 1987
Ehi ehi, my my, il rock 'n' roll non morirà mai, perlomeno finché rocker come Neil Young continueranno a fare dei ritorni come Rust Never Sleeps, il risultato di un tour in cui suonò per la prima volta questi brani e ne registrò le basi dal vivo. Il disco arrivò dopo che per anni Young aveva sfornato incisioni opache o indifferenti. Questo disco non arrivò come un vero e proprio shock (Neil Young è un tipo da cui non ci si può attendere che segua un sentiero risaputo e scontato, nemmeno nel caso del suo declino artistico), ma una sorpresa deliziosa; per metà acustico e per metà elettrico, quest'album mostrò Young al lavoro con la profondità di un veterano e il vigore di un ragazzaccio. Una raccolta di favole complesse nello spirito degli Indiani d'America a fronteggiare un futuro incerto e minaccioso, Rust Never Sleeps tocca la maggior parte dei temi visitati da Young fin dagli ultimi anni '60 rimettendoli in una forma sonora inaspettatamente succinta e convincente. Sia che si venga attirati dal senso casalingo e folkeggiante delle sue canzoni acustiche, che dal trash indisciplinato del suo lavoro elettrico, si trova sempre qualcosa che piace in Neil Young: le ballate senza accompagnamento del primo lato sono le più amabili del suo repertorio, i rock della seconda facciata le più ruvide.
Il lato acustico si apre con “My My, Hey Hey (Out Of The Blue)”, un brano dalla forma così disadorna da farlo sembrare un affettuoso, simpatico saluto ai Sex Pistols e allo spirito del rock. “Thrasher” è una vivida e ossessionante ballata su (scegliete voi) la tecnologia incontrollata o su CSN. Le tre canzoni seguenti (“Ride My Llama”, “Pocahontas” e “Sail Away”) esplorano il fascino che da lungo tempo esercitano su Young gli spazi aperti e la nobiltà dei selvaggi. Le immagini sono indelebili, ma rese cruciali dalla loro intelligente asciuttezza. Giri il disco e trovi Young alle prese con la rabbia viscerale di Johnny Rotten a suonare l'hard rock più distruttivo che abbia mai fatto. “Welfare Mothers” e “Sedan Delivery” sono abrasive e brucianti, mentre “Powderfinger” cattura il sentimento della sopraffazione, di chi è alla deriva e condannato puntando il dito sulla prepotenza del potere. Infine c'è “Hey Hey, My My (Into The Black)” nella quale riprende la canzone iniziale suonandola con una furia controllata a malapena. Le due versioni drammaticamente differenti di questa canzone sono unite dalla semplice fede di Young nel potere trasformista del r'n'r, potere che mai prima d'ora aveva utilizzato così pienamente.
Rolling Stone 1987
I 50 momenti che hanno fatto la storia del rock, Speciale Rolling Stone